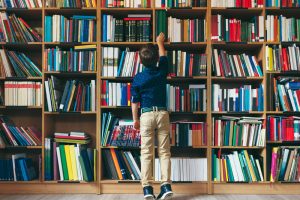Un modello di tutela ambientale partecipata, focalizzato su un territorio fragile e prezioso come quello dei Monti Lucretili, con i loro muretti a secco e i sistemi agricoli sostenibili
Rigenerare il territorio significa, prima di tutto, conoscere a fondo ciò che lo ha plasmato nel tempo: la sua morfologia, la sua storia, le sue vulnerabilità. È il cuore del lavoro guidato dalla professoressa Sara Carallo, geografa e ricercatrice dell’Università Roma Tre, che insieme alle colleghe Carla Masetti ed Emeri Farinetti ha portato all’interno del progetto Changes una ricerca capace di unire geografia storica, archeologia del paesaggio e tecnologie avanzate. Il titolo è tecnico – “Il paesaggio terrazzato dei Monti Lucretili. Esperienze di citizen science per la rigenerazione territoriale” – ma il risultato è sorprendentemente concreto: un modello di tutela ambientale partecipata.
LEGGI ANCHE – CHANGES, l’Italia del patrimonio culturale guarda avanti
Il progetto prende avvio da un territorio fragile ma prezioso: i paesaggi terrazzati dei Monti Lucretili, porzione del Subappennino laziale dove per secoli le comunità hanno scolpito il terreno con muretti a secco e sistemi agricoli sostenibili. Non solo un patrimonio culturale, ma un vero argine ecologico: queste strutture, riconosciute dall’UNESCO come Patrimonio Immateriale dell’Umanità, stabilizzano i versanti, rallentano l’erosione, riducono il rischio idrogeologico. Eppure oggi sono minacciate dall’abbandono, dallo spopolamento e dagli effetti crescenti dei cambiamenti climatici.

La ricerca di Sara Carallo, Carla Masetti ed Emeri Farinetti: il territorio come laboratorio ambientale
La ricerca – parte dello Spoke 7: Patrimonio culturale e cambiamenti climatici – utilizza un arsenale di strumenti high-tech: droni per la fotogrammetria, camere termiche, sensori LiDAR, GPS differenziali, affiancati a fonti d’archivio e testimonianze orali. Un approccio ibrido che permette di leggere il paesaggio come un organismo vivente con memoria propria, identificando le zone più vulnerabili e quelle che necessitano interventi urgenti.
Al centro del metodo, però, non c’è la tecnologia: c’è la Citizen Science.
Cittadini, associazioni, studenti, enti locali e personale del Parco collaborano attivamente con i ricercatori. Mappano sentieri, raccolgono dati, segnalano crolli dei muri a secco, partecipano a laboratori e interviste. Un lavoro corale che trasforma la comunità in presidio ambientale e conoscitivo.
“Abbiamo camminato moltissimo con gli abitanti – racconta Carallo – perché il territorio non si capisce soltanto negli archivi. Bisogna attraversarlo, ascoltarlo e, soprattutto, ascoltare chi lo vive. Solo così si individuano strategie reali per proteggerlo dai cambiamenti climatici e dall’abbandono”.
Muretti a secco: infrastrutture verdi contro l’emergenza climatica
Tra le attività più significative c’è stato il recupero dei muri in pietra a secco, realizzato grazie alla collaborazione con artigiani locali. Non semplici manufatti, ma infrastrutture ecologiche ante litteram, capaci di consolidare i terreni, ridurre il ruscellamento e trattenere biodiversità. La loro ricostruzione non è solo un atto di manutenzione: è un gesto educativo, un esercizio di consapevolezza ambientale che restituisce alle comunità un ruolo attivo nella tutela del proprio paesaggio.
Un modello ambientale che unisce discipline, tecnologie e persone
La ricerca mostra con chiarezza come le discipline umanistiche possano incidere sulla sostenibilità: la geografia diventa strumento di adattamento climatico, l’archeologia del paesaggio una lente per leggere le vulnerabilità territoriali, le tecnologie digitali un supporto alla pianificazione ambientale.
E soprattutto, la Citizen Science diventa motore di rigenerazione ecologica.
Il progetto dei Monti Lucretili è, in fondo, un piccolo manifesto: per proteggere l’ambiente serve un nuovo patto tra sapere accademico e comunità. Serve uno sguardo che integri storia e innovazione, memoria e resilienza climatica. E serve una geografia capace di uscire dai libri per tornare nei luoghi.
Una scienza antica, sì, ma più che mai necessaria per affrontare il futuro.
ASCOLTA ANCHE TALK THE CHANGES, il podcast che racconta il cambiamento attraverso le persone che lo vivono e lo creano